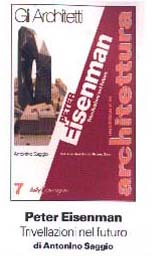Saggio su Eisenman
di Sandro Lazier
- 11/9/2001
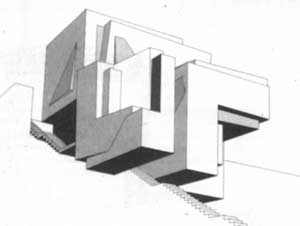
|
"Peter Eisenman - Trivellazioni
nel futuro" di Antonino Saggio non solo un testo
importante e penetrante per la conoscenza di un architetto contemporaneo.
E' un testo soprattutto illuminante. |
||
|