Terragni ibernato?
di Paolo G.L. Ferrara
- 6/4/2004
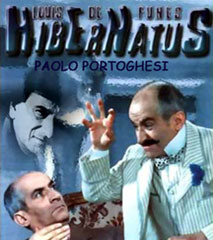
Chi stato a Poggioreale ha di certo visto Piazza Elimo. Parlo di Poggioreale
nuova, ricostruita interamente dopo il terremoto del 1968, a valle rispetto
al sito originario del XVII secolo.
Qualche sparuto cultore di architettura, inoltratosi nella fondovalle Sciacca-Palermo
alla ricerca di Gibellina Nuova, passa anche da qui per visitare lopera
di Paolo Portoghesi, datata 1986, nel pieno del suo delirio post modernista.
Realizzata nel 1990, essa rappresenta la spasmodica voglia di auto celebrazione
dellarchitetto romano, istericamente proiettato nellintento di riaffermare
la teoria illustrata in Dopo larchitettura moderna, libro
edito nel 1980, anno della Strada Novissima, evento oramai storicizzato quale
momento cardine dellufficializzazione del Post Modern architettonico nella
versione variante italiana.
E lopera di Poggioreale ne lemblema in cui si materializza
linutile sforzo di ricercare nella memoria di archi, capitelli, cariatidi
e trabeazioni la rinascita dellarchitettura oltre l ...ideologia
del Movimento Moderno, quella che per affermarsi attraverso lo statuto
funzionalista, come dice Portoghesi, doveva necessariamente postulare il
primato del tempo sul luogo, questo sradicamento totale di una disciplina dalle
sue condizioni materiali di origine e di sviluppo, rinnegando cos
qualsiasi rapporto con la storia.
Costatato che, visto che la struttura urbana del vecchio insediamento si sviluppava
attraverso una scacchiera che aveva comunque un impianto orografico assolutamente
dinamico, lintervento architettonico di Poggioreale nulla ha a che fare
con limpianto originario del paese distrutto dal terremoto, ci si chiede
che senso abbia la presenza di Paolo Portoghesi quale membro del comitato scientifico
dellorganizzazione dellanno dedicato al centenario della nascita
di Giuseppe Terragni (GT04).
Cosa centra Poggioreale con Terragni? Appunto, che centra? Che significato pu
avere che il massimo esponente italiano della restaurazione accademica sia lanfitrione
del mondo di Terragni, ovvero il massimo esponente italiano della lotta allaccademia?
Soprattutto, risulta assolutamente fuori luogo che sia proprio Portoghesi ad
inaugurare le celebrazioni con la conferenza "Terragni, italianit
di un architetto europeo". Il perch chiaro se solo
si legge quello che lobiettivo della conferenza,e cio
...affrontare il problema del rapporto tra Terragni e il Fascismo e
la difficile scelta dellarchitetto comasco di conciliare la sua adesione
al movimento moderno, come si era configurato in Europa negli anni venti, con
la volont di esprimere in quellambito una specificit italiana
legata ad una idea di tradizione come innovazione nella continuit.
Si tratta di unoperazione assolutamente pericolosa, soprattutto se la
si inquadra nellottica portoghesiana di volere continuare lopera
demolitrice del Movimento Moderno, stavolta usando a pretesto Giuseppe Terragni
cos come risulta chiaramente dai temi della conferenza quando se ne
parla quale uomo/architetto costretto ad affrontare la difficile scelta di conciliare
ladesione al MM senza, al contempo, trascurare la tradizione, il tutto
nel pieno del regime fascista.
Stupisce non poco che nel libro Dopo larchitettura moderna,
capitolo settimo, allorquando parla proprio del periodo fascista, Portoghesi
accenni assolutamente superficialmente allarchitetto comasco, limitandosi
a sottolineare che la morte di Terragni (e di Pagano) aveva lasciato
il fronte dei razionalisti sostanzialmente acefalo. Invece di riannodare
la revisione del Movimento Moderno al lavoro di erosione che Terragni ne aveva
iniziato in tempo reale, il fine di Portoghesi esclusivamente quello
di sottolineare la sostanziale differenza tra i razionalisti italiani e quelli
europei, rintracciandola in una pi attenta volont di recuperare
il rapporto con la tradizione da parte dei nostri, piuttosto riottosi a sposare
lastrazione pura e assoluta di Oud, Gropius, Mies e
Le Corbusier, che non contemplava alcun rimando alla storia. Eppure, da quanto
risulta dagli scritti del Gruppo 7 su "Rassegna Italiana" sembra
proprio che Terragni, pur non rinnegando il lavoro dei neoclassici, avesse le
idee molto chiare sulla nuova architettura italiana rispetto alle influenze
provenienti dallestero, cercando di equilibrare il continuo fermento intorno
allarchitettura quale arte di Stato con quello direttamente riferito allarchitettura
quale fatto sociale direttamente derivato dalle ricerche estere.
In realt, lo sforzo di Terragni sembra essere quello di mediare le richieste
del Regime con le personali convinzioni sulla nuova poetica architettonica,
e ci risulta assolutamente chiaro a proposito del concetto di simmetria
che il Gruppo 7 prende a prestito quale riferimento alla tradizione italiana,
ma che cerca di spogliare dalle implicazioni classiciste: ...lo spirito
della tradizione cos profondo in noi che, necessariamente e
quasi meccanicamente, la nuova architettura non potr non conservare
unimpronta tipicamente nostra [...]Questo prova quanto siano infondati
i timori di uneccessiva influenza estera: per esempio, una delle caratteristiche
delle pi recenti architetture tedesche e olandesi unassoluta
asimmetria, tanto nelle masse che negli elementi; ora, mentre non possiamo negare
che da questo partito traggono risorse notevolissime e interessanti risultati,
tuttavia dobbiamo riconoscere che esso non finisce di accontentare lestetica
italiana.
Per lappunto: si parla di estetica, non di spazialit;
e che sia un tentativo di conciliare le parti rispetto alla semplice riconduzione
a riferimenti estetici lo conferma la conclusione dello scritto: Il substrato
classico che in noi richiede, se non una simmetria assoluta, per lo
meno un gioco di compensazioni che equilibri le varie parti. Ecco, fra le altre,
una sicura garanzia dindipendenza per larchitettura italiana, e
una ragione di profonda originalit. (da: Gruppo 7, Architettura
-IV - 1927)
Portoghesi, come suo solito, tira di fioretto: sfruttando la questione dei riferimenti
alla tradizione italiana tenta di smontare limpeto di Terragni nellintroiettare
linsegnamento di Le Corbusier, cos da alienare i concetti del
rapporto con la tradizione al di fuori di quelle che ne erano le vere basi,
ovvero quelle della ricerca spaziale. E a poco serve citare Michelangelo e Borromini
se poi si stagna nelleffimero riferimento ad una tradizione che nulla
ha a che fare con quella che lo stesso Portoghesi ha tentato, sino ad ossessionarci,
di riproporre, che poi la stessa a cui si riferisce quando ironicamente
parla dell E 42 (oggi EUR) dove ...sotto la regia di Piacentini
erano stati frettolosamente rimessi in auge archi e colonne.
Di fatto, la continuit con la tradizione di cui attraverso le sue architetture
ci parla Terragni non poteva che essere spaziale, dunque tuttaltra rispetto
a quanto ha invece fatto Portoghesi negli anni 80 del secolo scorso.
Ed proprio lo stesso Portoghesi (presumibilmente involontariamente)
a rimarcare la netta differenza tra la sua posizione e quella di Terragni rispetto
al recupero della tradizione: Che Terragni non abbia mai fatto compromessi
evidente; egli un uomo del suo tempo e quindi, per lui, la
tradizione non un problema di rispetto per la continuit formale
o di un certo repertorio linguistico . (da: I grandi architetti del
Novecento, Newton & Compton 1998). Precisamente, e infatti Terragni evita
sempre di scadere nella retorica monumentale, Portoghesi invece ci sguazza,
ed altres del tutto improponibile cercare di ridurre lopera
di Terragni al "raro uso dello spazio antiprospettico" cos
come fa Portoghesi prendendo a prestito la Casa del fascio: Questo
un punto su cui lopera di Terragni molto chiara: solo
raramente egli antiprospettico, mentre c sempre un forte
residuo di ricerca della profondit che si esprime magistralmente nella
facciata principale della Casa del fascio.
Passi pure la "ricerca della profondit" ma solo se
la si considera dal punto di vista della trasformazione del muro pieno in diaframma
di trasparenza, concetto che non pu essere disgiunto da quello della
continuit interno/esterno, avvalorato dal vuoto spaziale dellatrio.
E proprio nella Casa del fascio che Terragni applica palesemente i significati
del substrato classico della tradizione italiana negandone per la simmetria
assoluta e lavorando alla scomposizione del cubo razionalista attraverso la
preservazione della sua continuit volumetrica, il che significa proprio
compensare gli equilibri tra le varie parti.
Terragni raggiunge qui la piena maturit rispetto alle concezioni del
purismo di Le Corbusier. E se maturit significa porsi in senso critico,
Terragni lo fa iniettando nella casa del Fascio la volont di scardinare
la perfezione stereometrica senza eliminarla ma coniugandola con la volont
di esprimere il dinamismo spaziale: le quattro facciate ne sono il momento esplicativo
perch in esse che confluisce e defluisce lo spazio. Non esiste
un solo fronte in cui gli elementi vuoti siano posizionati simmetricamente,
rimandando cos agli angoli, vero elemento base della composizione. La
fluenza spaziale tra interno ed esterno marcata dalla stessa struttura
puntiforme che fuoriesce solo nel fronte dingresso: sono infatti i pilastri
a dettare la variazione di profondit, sia orizzontalmente che verticalmente.
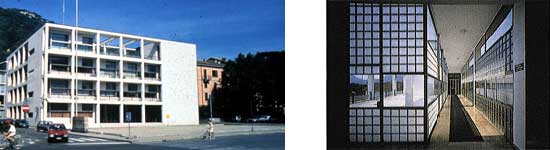
Linterpretazione del fascismo quale casa di vetro raggiunge
la massima espressione, se vero che la casa vuole esprimere lo stretto
legame tra gerarchia fascista e popolo e cos il salone delle riunioni
si apre grazie ad una grande vetrata verso la corte interna, a sua volta legata
alla piazza antistante attraverso lapertura delle vetrate continue poste
al piano terra. Non vi soluzione di continuit rispetto alle
fluenze spaziali e ci innesca un dinamismo che coinvolge anche limpianto
strutturale: entrando nella corte interna i pilastri sul lato sinistro, raggiunto
il ballatoio, si piegano nello scatto orizzontale delle travi che, a loro volta,
vanno ad aggredire il muro/lastra che delimita il salone delle riunioni. Il
ballatoio diventa elemento spazialmente vuoto che si coglie in tutta la sua
espressivit nel momento in cui vi si sbarca dalla scala principale,
dando la possibilit, visiva e fisica, a tre possibili direzioni: a sinistra,
verso laccesso al ballatoio esterno sul fronte principale; frontalmente,
verso lufficio del gerarca, la cui porta un elemento smaterializzato,
visto che si tratta di una paratia completamente vetrata che si stacca dai muri;
verso destra, con la scala secondaria che si staglia in verticale e la cui parete
di fondo completamente vetrata sembra proiettarci al di fuori delledificio.
Se la profondit prospettica di cui parla Portoghesi ridotta
alla visione bidimensionale della facciata principale ecco che il contenuto
espressivo della Casa del fascio si perde del tutto, lasciando per strada la
sostanza dei riferimenti a Michelangelo e a Borromini, ovvero lelemento
che permette a Terragni di andare oltre la classicit (e non indietro
nellaccademismo classico) rispetto agli schematismi dellastrazione
purista. Al contrario di quanto affermato da Portoghesi rispetto ai significati
del riferimento alla tradizione, nelle opere di Terragni non vi traccia
della chiara volont di recuperare laspetto figurativo e simbolico
dellarchitettura ma, piuttosto, di riproporre secondo un lessico contemporaneo
le ricerche del passato sullo spazio dinamico, lessico che per sua stessa genesi
aveva eliminato qualsivoglia elemento stilistico riconducibile alla tradizione.
E se Terragni impara qualcosa dal passato, proprio sulla capacit
di Michelangelo e Borromini di erodere le impostazioni classiche che va posta
lattenzione: nellEdicola funeraria Pirovano 1930-1931 i muri si
spogliano dalle modanature e la scatola stereometrica scavata e sezionata,
ma i suoi lati restano evidenti. Quello dellerosione un tema
che Terragni non tralascer mai nelle sue opere.
Leggere Terragni significa eliminare a priori la ricerca nelle sue opere della
simmetria poich una tale impostazione fuorviante rispetto alle
finalit che esse avevano. Valga per tutti lesempio del Novocomum,
di cui Portoghesi, pur di rinnegare la presenza di riferimenti spaziali al Costruttivismo,
cerca in tutti i modi di costringerci a leggere ledificio in tuttaltro
modo da quello che dovremmo: Nel Novocomum presente certamente
la lettura costruttivista che si pu facilmente amplificare fotografando
ledificio dallangolo e non facendo vedere che la facciata principale
rigorosamente simmetrica.
Significa forse che la lettura di unopera va fatta per parti, sezionata
e ricondotta pezzo per pezzo a determinati stili? No, Portoghesi vuole arrivare
a ben altro, ovvero a dirci che ... il disegno di Terragni fa capire
che c anche un altro tipo di interpretazione, uninterpretazione
plastica di gusto classico che non ha assolutamente nulla a che fare con la
poetica del costruttivismo sovietico, di cui si servito solo in superficie.
A dirla tutta, vero proprio il contrario, visto e considerato che
limpianto simmetrico chiaro solo bidimensionalmente (piante):
se innegabile che una stecca sembra raccordarsi al corpo retrostante
tramite elementi circolari, altrettanto vero che Terragni capovolge
il concetto nel momento in cui alza ledificio tridimensionalmente. La
stereometria pura aggredita tramite lo scavo e laggetto angolari
e con luso del colore, che marca rientranze ed aggetti. Il corpo cilindrico
vetrato posto agli angoli trova continuit nella fascia in muratura che
si slancia in orizzontale sulla facciata, dando cos continuit
ai diversi elementi. Le scale daccesso non sono in asse con gli ingressi
e, proiettandosi oltre lambito delledificato, legano larchitettura
alla citt. Lultimo piano aggetta langolo a spigolo vivo
direzionando il punto di vista in diagonale rispetto ai fronti. E la prima
architettura in cui Terragni esprime pienamente lattenzione verso la cultura
che era gi storia dello sviluppo del pensiero architettonico in Europa,
da Le Corbusier a Oud, da Gropius a Mendelsohn, al costruttivismo. Ma
d certo unattenzione che va oltre il semplice seguire precetti.
Chiss perch in Italia non si riesce a dire no!.
Chiss perch le celebrazioni del centenario debbano avere quale
deus ex machina un personaggio che non ha deliberatamente apprezzato chi ha
realmente cercato di dare continuit e contemporaneit alla inestimabile
opera culturale di Terragni: Peter Eisenman e Bruno Zevi in testa, che dal 1968
in poi diedero nuova linfa vitale allopera del comasco, riattualizzandola.
Il lavoro di Peter Eisenman su Terragni infatti ascritto da Portoghesi
nella sfera della autoreferenzialit: Il
suo itinerario inizia con le celebri case numerate da 1 a 11 come le opere di
un musicista. Il punto dichiarato di partenza Terragni e due sue opere
in modo particolare: la Casa del fascio di Como e la casa ad appartamenti Giuliani-Frigerio.
Su questi prototipi Eisenman conduce indagini critiche soggettive che lo guidano
nella sua avanzata verso lastrazione, considerata obiettivo supremo. Che
Terragni sia solo un pretesto lo riconosce lo stesso architetto che, a detta
di Antonino Saggio, in una conferenza dichiara: 'Terragni non esiste, Terragni
lho inventato io, Terragni sono io".

Sar pure stato un pretesto, ma il fatto che Eisenman abbia scelto Terragni
vorr pur dire qualcosa, soprattutto se relazioniamo la ricerca di Terragni
alla volont di andare oltre lastrazione purista, mettendola in
discussione e con essa tutti i pericoli di codificazione di un linguaggio in
stile. Eisenman individua in Terragni la potenzialit inespressa del
Movimento Moderno e nella House I e House II i riferimenti alla ricerca del
comasco nella Casa del fascio e nella casa Giuliani-Frigerio sono assolutamente
evidenti, cos come mette in evidenza Antonino Saggio: Sempre
interessato alle differenze, alle frizioni, alle opposizioni, egli [Eisenman]
attratto da due opere del comasco in contrasto luna con laltra.
Fra la casa del fascio e la Giuliani-Frigerio (le uniche su cui pubblica dei
saggi) lopposizione si basa sul diverso meccanismo di 'stratificazione'
che le ha generate. Nella Casa del fascio un processo che parte dallesterno
(la stereometria del prisma) verso linterno. Lesito noto:
pur conservando la purezza della forma primaria, Terragni riesce a conferirle
una tensione astratta (con partiture a tutta altezza che si alternano asimmetricamente
nei fronti) e dinamica (perch i diversi spessori delle stratificazioni
sul volume invitano continuamente a unesplorazione delledificio.
In una parola, un processo di estrazione.
La casa Giuliani-Frigerio, invece, basata su un processo di esplosione.
La stratificazione non si muove da fuori a dentro, ma allinverso. Lesito
lo slancio dinamico dei piani e dei volumi, che non vengono pi
trattenuti da una virtualit originaria, ma invadono lo spazio. Il problema,
per un ricercatore di nuove tensioni quale Eisenman, quello di lavorare
dentro questa differenza, dentro questa tensione fra estrazione ed esplosione.
Detto ci, alquanto pretestuoso che Portoghesi (usando, tra
laltro, proprio una frase di Saggio) cerchi di ridurre il tutto alla volont
di Eisenman di volere annullare qualsivoglia riferimento alla storia . Dice
infatti Portoghesi: La tradizione dellarchitettura moderna, da
Gropius a Mies a Wright, non giunge mai a negare la forza degli archetipi architettonici,
anzi li invera sottraendoli alle incrostazioni eclettiche che li avevano omologati.
Per Eisenman, come sottolinea correttamente Antonino Saggio, 'non esistono pi
figure date a priori (il tetto, la finestra, ledicola, il portico) ma
segni astratti, senza significato proprio, che vengono, come nei quadri dei
pittori, accostati in nuove dinamiche composizioni'. Lamnesia volontaria
quindi, che nella stagione alta del Moderno fu pi unintenzione
che un risultato raggiunto, dovrebbe, secondo questa teoria, non soltanto rimuovere
o rendere inconscia la memoria, ma estirparla come si estirpa un cancro. Va
da s che nella sostanza, pi che di continuit rispetto
alla tradizione moderna, si tratta in questo caso di una radicale revisione
[...] Eisenman va nella direzione della autoreferenzialit del segno
architettonico e quindi della sterilizzazione assoluta di un linguaggio che
delle sue molteplici valenze, quella civile, quella religiosa, quella artistica,
conserva la valenza puramente artistica, attribuitagli nel clima estetizzante
della fine del secolo scorso.
Al di l di qualsivoglia elucubrazione, credo sia assolutamente chiaro
che Portoghesi non riconosca alcun merito alla ricerca di Eisenman su Terragni.
In merito al lavoro di Bruno Zevi c poco da dire: Portoghesi,
affermando che ...non abbiamo visto una storia che riconosca in pieno
il valore di Terragni ne disconosce la validit, disconoscendo
il peso culturale delle celebrazioni del 1968 (25 anno dalla morte).
Rileggendo quanto Zevi scrisse presentando levento non possono sfuggire
le sue preoccupazioni sul futuro dellarchitettura che negli anni 70
e 80, e con Portoghesi quale protagonista, si sarebbero verificate: Lanniversario
di Terragni deve costituire un richiamo alla tensione razionale, forse decisivo
per gli architetti italiani che la societ del benessere e la psicologia
di un mondo affluente e insicuro hanno indotto ad evadere in ricerche di natura
affettiva, per non dire umorale. Nei venticinque anni che ci separano dalla
morte di Terragni, il loro linguaggio si notevolmente arricchito, la
volgarit monumentalistica stata debellata, mentre il parametro
urbanistico veniva assimilato. Ma, proprio nellora della sua vittoria,
il movimento moderno si infiacchito producendo nel suo stesso grembo
i germi della corruzione: le preoccupazioni cosiddette 'ambientistiche', le
citazioni 'della memoria', le vene storicistiche , il ritorno ad impianti bloccati,
classici, statici, anche se se configurati secondo le formule delle finestre
a nastro e dei prismi di cristallo. Urge riesaminare questo confuso cammino
vagliandolo sulla bilancia dellempito razionalista degli anni trenta,
per individuarne le carenze e i tarli. [...] Il Novocomum, lasilo infantile
del rione SantElia, gli appartamenti Giuliani-Frigerio e, perch
no?, la casa del Fascio, che di fascista non ha neppure una remota impronta,
sono opere tuttora incalzanti nel loro messaggio; anzich oggetti del
passato da ammirare passivamente, offrono stimoli sferzanti allattuale
inerzia creativa. (da: Cronache di architettura, n.692, 31.12.1967).

Timori, quelli di Zevi, confermati anni dopo nella piazza Elimo di Poggioreale,
dove di Terragni e della sua eredit non c proprio nulla.
Comunque sia, Portoghesi accontentato: la tradizione, almeno quella
del non sapere dire di no! a chi gestisce il potere, sempre
attuale. Libernazione dellarchitettura italiana salva,
basta fare credere di essere ancora nel passato, cos come Hubert de
Tartas (Louis De Funes) fece con il nonno della moglie, creduto morto e ritrovato
congelato tra i ghiacci polari. Daltronde, sempre di comiche si tratta.
Senza indugi: questo delle celebrazioni su Terragni forse il momento
in cui, da quattro anni a questa parte, si sente pi forte la mancanza
di Bruno Zevi che, ne siamo certi, avrebbe saputo dire no! a Portoghesi
anfitrione di Terragni e della sua sofferta e combattuta coerenza. Qualit
che a Portoghesi non appartiene di certo.

(Paolo G.L. Ferrara
- 6/4/2004)
Per condividere l'articolo:
|
|
Altri articoli di Paolo G.L. Ferrara |
|
Invia un commento all'articolo |
|
|
Stampa: "Terragni ibernato?.pdf" |








Commento 738 di Carlo Sarno del 25/05/2004
Zevi scrive di Terragni : "opere tuttora incalzanti nel loro messaggio; anzich oggetti del passato da ammirare passivamente, offrono stimoli sferzanti allattuale inerzia creativa. (da: Cronache di architettura, n.692, 31.12.1967).
E Ferrara , autore dell'articolo , scrive : " nelle opere di Terragni non vi traccia della chiara volont di recuperare laspetto figurativo e simbolico dellarchitettura ma, piuttosto, di riproporre secondo un lessico contemporaneo le ricerche del passato sullo spazio dinamico, lessico che per sua stessa genesi aveva eliminato qualsivoglia elemento stilistico riconducibile alla tradizione. E se Terragni impara qualcosa dal passato, proprio sulla capacit di Michelangelo e Borromini di erodere le impostazioni classiche che va posta lattenzione.... Quello dellerosione un tema che Terragni non tralascer mai nelle sue opere.
Leggere Terragni significa eliminare a priori la ricerca nelle sue opere della simmetria poich una tale impostazione fuorviante rispetto alle finalit che esse avevano... " .
Ringrazio Bruno Zevi e Paolo Ferrara per queste loro precisazioni che colgono un punto essenziale della poetica di Terragni, ed aprono ad una pi profonda comprensione del grande architetto poeta-razionalista italiano. Si, poeta-razionalista credo che sia l'unica esatta denominazione di Terragni. In lui, e lo si evince dalle sue opere, il razionalismo viene sublimato nella poesia, ma non con forzature, con una azione appariscente ed eclatante, ma con l'eleganza e la semplcit che proprio del maestro. E' il suo un linguaggio architettonico che incarna l'ideale democratico del valore della persona e dell'ndividuo, in cui la diversit ed il divenire formale si radicano sulla tradizione senza restarne ingabbiati. Anzi la sua architettura, che potremo definire "razionalismo-poetico", esprime al meglio una istanza creativa originale - per dirla con Zevi - e ancor pi - come indica Ferrara - Terragni erode l'impostazione classica, ma non nelle strutture superficiali ma in maniera profonda .
In tal senso, la Casa del Fascio si pu ben definire un'opera "cubista" in cui l'imprevedibilit ed il diverso giocano un ruolo essenziale. Occorre girare intorno all'opera del maestro, entrare all'interno, percepirne le trasparenze e continuit sinestetiche per apprezzarne il valore .... ma non tutto ... occorre spostarsi dal piano del significante al piano linguistico del significato e coglierne - miracolosamente proprio in un'epoca totalitaria - il profondo messaggio di libert e democrazia, fierezza morale, dignit e valore della persona.
Grazie di cuore Giuseppe Terragni! Tu insegni agli architetti italiani che non ci sono scuse, che non c' alcuna giustificazione morale per chi non svolge la sua missione di architetto oggi: promuovere creativamente uno spazio per il bene dell'umanit .
Carlo Sarno
[Torna su]
[Torna alla PrimaPagina]